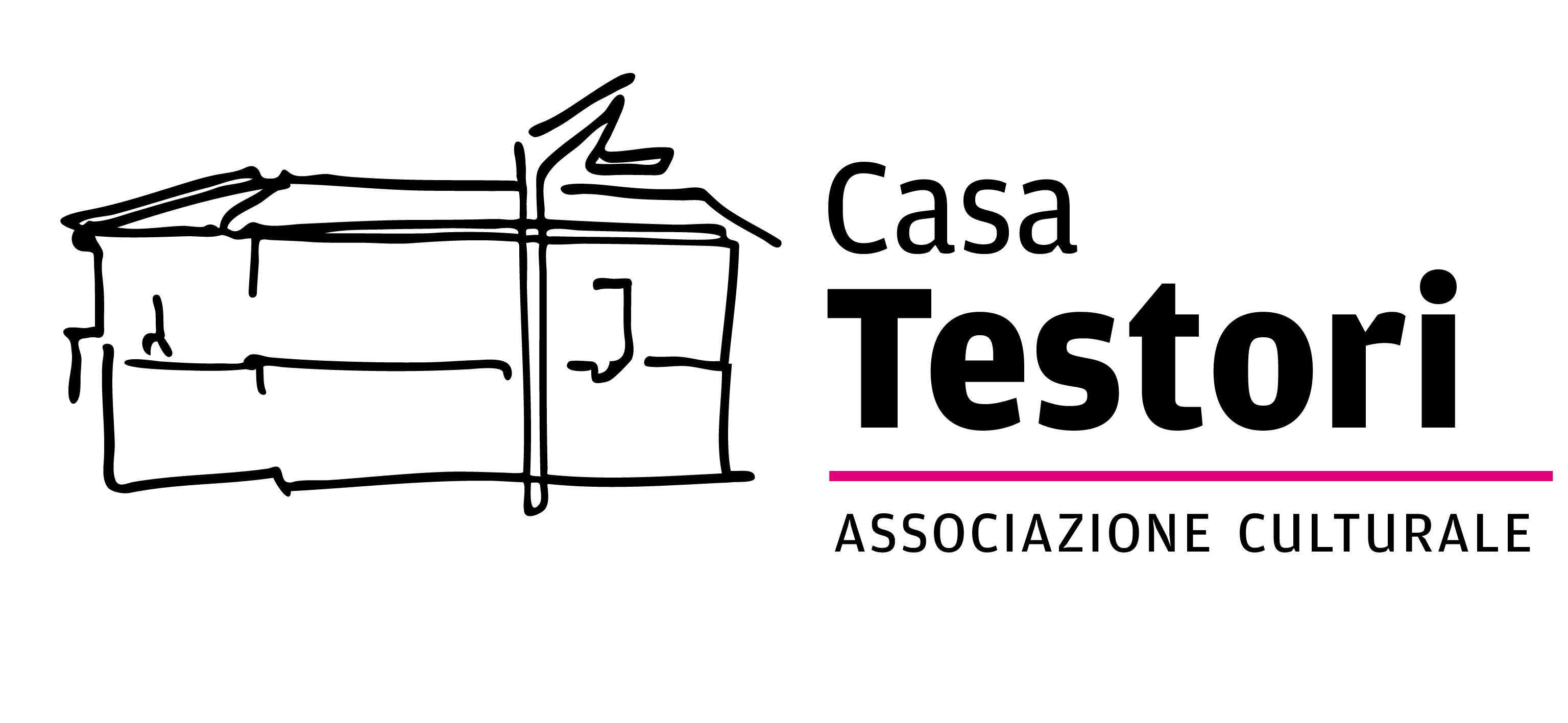Stanza 7
Invitato da Andrea Mastrovito
Quello tra Mario Schifano e il gallerista modenese Emilio Mazzoli è stato un rapporto fondamentale per entrambi dagli anni Ottanta. Le 700 foto che erano presentate sono tratte dalla collezione personale del gallerista che ne acquistò da Schifano alcune migliaia. Le celebri foto scattate alla televisione, stampate e ridipinte, esprimono a pieno la poetica e la prassi pittorica dell’artista nell’ultimo decennio della sua vita: la sua passione per i mezzi di comunicazione e la sua bulimia visiva. Come ricorda il suo storico segretario, Renzo Colombo: “Passava tantissimo tempo a lavorare sulle fotografie che scattava alla televisione e che poi ritagliava e colorava. Con le foto Mario si staccava da tutto e da tutti. Per un periodo ha consumato venti rullini al giorno, portavo al laboratorio di stampa venti rullini al giorno! Diceva: “È questo adesso il vero lavoro di qualità, non i quadri’”.
Come precisa l’amico Roberto Ortensi, storico assistente della gallerista Ileana Sonnabend: “Tutto partiva dalle immagini fotografate alla televisione, spesso sfocate o con strani bagliori azzurrini, figure che evocano un altrove, un qualcos’altro, su cui lui a volte interveniva con il colore. Quando interveniva lo faceva quasi come un omaggio alla pittura, erano come dei segni, una specie di richiamo.
Quella delle foto ritoccate era un’occupazione veloce, ma anche misteriosa. Riusciva a far saltar fuori dalle immagini un’intensità e una profondità mai viste, impercettibili. Era come il lavoro di un rabdomante. Rivisitava con la pittura le immagini della realtà che gli arrivavano in casa dal televisore. Queste foto per un po’ rimanevano sul tavolo di lavoro, impilate e divise per generi”.Conclude Mazzoli: “Come sai Mario non era interessato al sacro ma per me il suo lavoro era un po’ come una religione e mi faceva venire in mente le suore di clausura che pregano sempre per arrivare all’atarassia. Lui faceva lo stesso, lavorava di continuo, o disegnava o dipingeva, la sua era come una forma di purificazione. Certo, poi aveva questo laicismo del volere tutto e subito. Ma queste foto erano il suo rosario: ne teneva un mazzetto sempre sottomano e mentre parlava con te o al telefono ci dipingeva sopra, sgranandole una dopo l’altra”.
Mario Schifano è nato a Homs (Libia) nel 1934. Muore a Roma nel 1998.