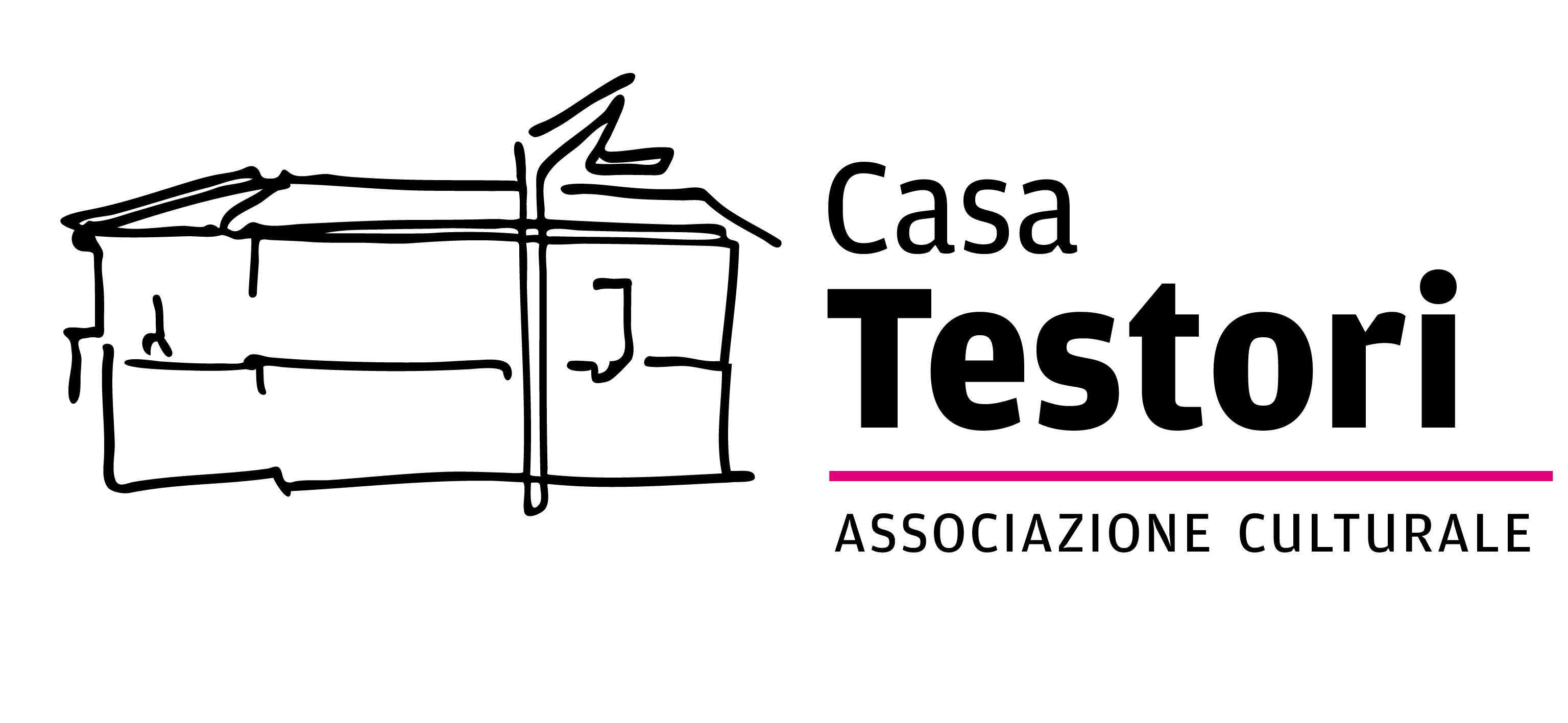Stanza 18
Horny Hotel è il titolo di un hard movie, Etat et Santè il titolo di uno studio socio-medico che, seppur malinteso, ispirò molta parte della politica eugenetica nazista.
Dopo l’esperienza del Novecento affianchiamo la privazione di libertà e di pensiero a una estetica del campo di sterminio. Vengono in mente irrimediabilmente il vuoto, l’estrema magrezza, i colori assenti e la passività. Dovremmo però oggi ripensare all’estetica dell’annichilimento umano, in forza del fatto che è diventato una delle caratteristiche del contemporaneo, non più legato all’idea di campo vuoto.
Al polo opposto del vuoto vediamo la condensazione di simboli, corpi, colori, riferimenti e stimoli. Come il vuoto, la presenza eccessiva impedisce il pensiero. Un luogo dove i riferimenti riempiono ogni spazio è un campo dove un potere coordinato può esercitare un controllo sul fruitore.
Nei due spazi che ho usato ho cercato di riprendere i temi che meglio si adattano a questa instaurazione di potere (in particolare la sessualità) e legarli a un’estetica satura; nello spazio del bagno, poi, ho rielaborato una foto storica della famiglia Testori ripresa in giardino (Testori masturbazione 1), facendo del giardino uno spazio denso ed eccitante, e dei Testori rimane solo un accenno di sessualità, al quale penso questo bagno abbia davvero assistito nel tempo.
Guido Nosari
L’accumulo dei densi grumi di colore con cui costruisce le sue forme, o meglio le de-costruisce plasticamente, ha un che di animale, atavico. Il più delle volte partendo da fotografie, l’artista “rovina” l’immagine, una volta, un’altra, e poi un’altra ancora, con l’accanimento di chi rivolta, rimesta il reale e la materia pittorica, cercando ciò che di drammatico (nel senso di azione, rappresentazione teatrale), di epico, vi si possa trovare.
Un accumulo, dunque, che è un percorso in profondità, un dentro che esplode fuori. Tutta la sovrabbondanza e il disordine che è il mondo “interiore” del “rappresentato” (e di ognuno di noi), che s’appiccica, s’impasta, alla parte “visibile”.
Ecco allora i corpi offerti nudi, e scarnificati, il rosso sangue (vita e morte) che colpisce gli occhi.
Tutto il contrario di un accanimento terapeutico, a dire: “muori, ma dimmi chi/cosa sei”. Come non pensare agli animali sanguinosi di Varlain, Soutine o anche al Giancarlo della mostra Testori a Lecco? Oppure al cumulo, al grido, alle figure caricaturali di Grosz?
Dunque il rosso, e da questo i rosa, e poi il blu. Colori, peraltro, delle messe in scena nei ritratti di Fra’ Galgario, bergamasco come Nosari, dei suoi fastosi costumi che sembrano contrastare con i volti invece “comunemente umani” (e Nosari ne scrive riguardo alla mostra del 2011 a Bergamo). Un contro altare, come in altra misura a Casa Testori.
Qui la densità della materia ha, in più, il suo contro altare nella piccola dimensione dei quadri, quasi una narrazione continua, “intima”. Oltretutto alcune fotografie origine dei dipinti ritraggono l’artista e suo fratello.
Unica eccezione la grande tela che è allestita in bagno, volutamente fuori misura nello spazio. Dipinta su un lenzuolo usato da Nosari, ripresa dall’unica fotografia della famiglia Testori al completo (altra foto “intima” e incisa sui muri della villa da Andrea Mastrovito), l’opera è totalmente ricoperta da una germinazione vegetale, da una elegante coda di pavone dispiegata. Accumulare e scavare per collegare e disvelare…
Francesca Radaelli
Guido Nosari è nato nel 1984 a Bergamo, dove vive e lavora.