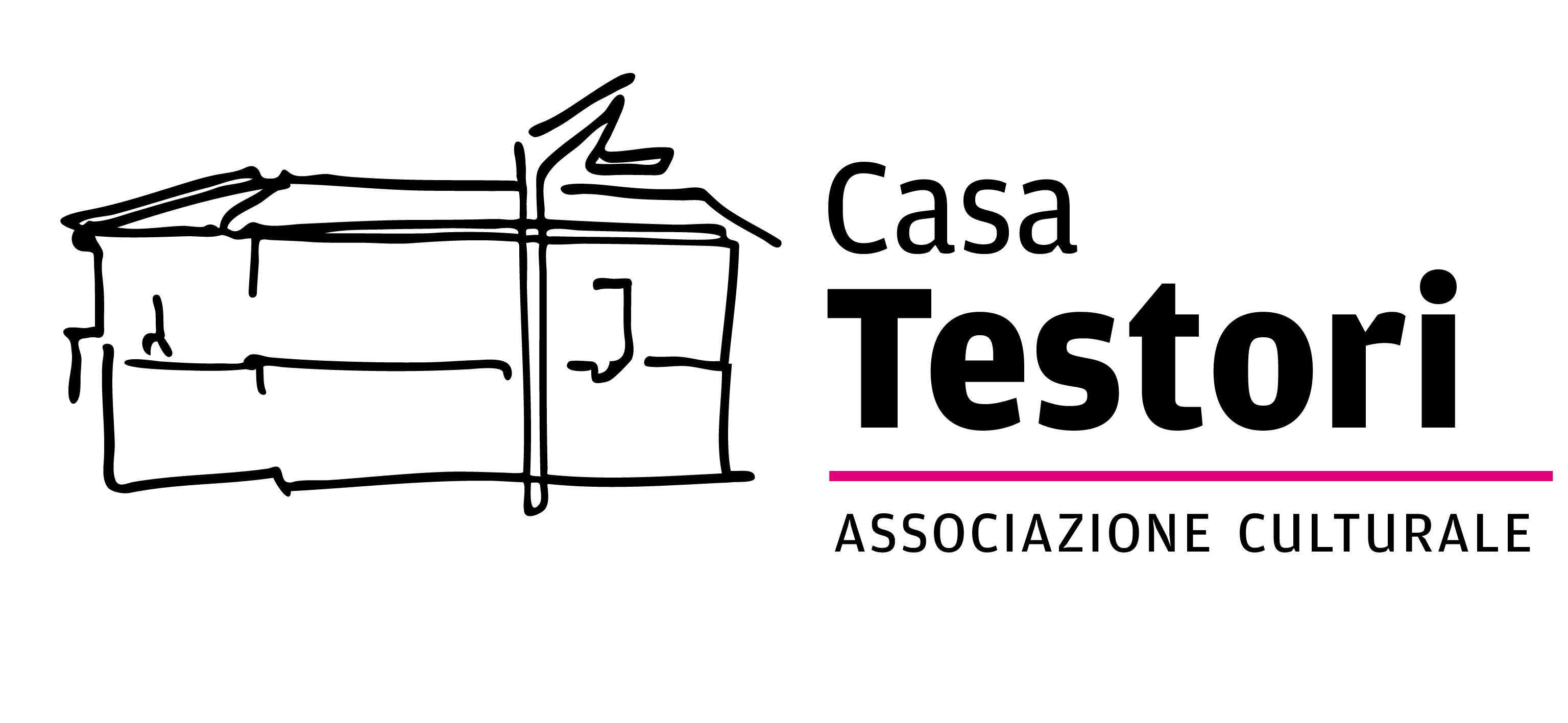Nel 1968 Franco Rossellini, il produttore di Teorema, propone a Pasolini la realizzazione di un film su Medea, con Maria Callas come protagonista. Il regista ne è immediatamente entusiasta: da tempo aveva pensato di coinvolgere il celebre soprano per un ruolo tragico. La Callas, da parte sua, conosceva Pasolini come regista, e ne aveva un’opinione confusa, i suoi film le avevano suscitato sentimenti contrastanti. I due si conoscono il 19 ottobre 1968 e per Pasolini è una folgorazione: Maria è “una straordinaria apparizione fisica” e scatta l’identificazione con l’eroina della tragedia greca. La Callas è Medea, Medea è la Callas e Pasolini scriverà la sceneggiatura del film calibrandola accuratamente sulla personalità della Divina. Conquistata dalla personalità di Pasolini, la Callas accetta il ruolo di Medea in un momento estremamente delicato della sua carriera e della sua vita: deve contrastare i tanti che la credono professionalmente finita, esce dalla tempestosa relazione con Aristotele Onassis. Il ruolo che Pasolini le offre è la sua possibilità di riscatto, ma è una prova tra le più difficili: si sente inadeguata, spaesata, frammentata dalla tecnica cinematografica, così diversa da quella teatrale in cui lei è maestra. Ma è proprio la presenza fisica e cara di Pasolini sul set nell’estate del 1969 che la sostiene e guida. Lo documentano in modo eccezionale le fotografie di Mimmo Cattarinich e la lettera inedita in cui Pasolini la rassicura sul piano professionale e umano. Questo sarà solo l’inizio di un rapporto destinato a durare nel tempo e Pasolini le manifesterà il suo amore nei modi concessi dai suoi mezzi espressivi: la poesia e il disegno. Nascono così un ampio numero di ritratti di Pasolini alla Callas, realizzati in due serie nel 1969 e nel 1970. Li accomuna una forte sperimentazione tecnica che approfondisce le esperienze del 1967. Il grande disegno qui esposto (1970) appartiene ad una serie di otto ritratti multipli di Maria Callas realizzati con matita, vino, colla e petali di rosa sulla spiaggia dell’isola di Skorpions, durante una vacanza in Grecia. Il volto della Callas diventa un profilo arcaico in cui ritorna la serialità indagatrice già provata su di sé nel 1965 e destinata a riemergere in altri ritratti del 1974-1975. Questo disegno, in particolare, è realizzato con colla vinilica e anticipa una dichiarazione del 1974: “Non ho potuto far niente né con la matita, né coi pastelli, né con la china. Ho preso un barattolo di colla, ho disegnato e dipinto, insieme, rovesciando direttamente il liquido sul foglio. Ci sarà una ragione per cui non mi è venuta mai l’idea di frequentare qualche liceo artistico e qualche accademia. Solo l’idea di fare qualcosa di tradizionale mi dà nausea, mi fa stare letteralmente male. Anche trent’anni fa mi creavo delle difficoltà materiali”.
casa testori
MARIA CALLAS, UNA PIETRA PREZIOSA
IO NINETTO E LAURA
Stanza 4
Negli anni ‘50, durante la stagione d’oro del cabaret italiano, Laura Betti (nata Trombetti) si distingue come artista singolare e fuori da ogni schema, acquistando una certa fama per l’inconfondibile timbro roco della voce, per i modi spudorati e anticonformisti, per il pessimo carattere e la falcata felina, che le varrà il soprannome di “Giaguara”. Laura aveva aperto la sua casa di via del Babuino a scrittori, poeti e giornalisti: vi arriva anche Pasolini, intorno al 1958, “trascinato”, per come ricorda la stessa Betti, da Goffredo Parise. Dalla frequentazione sempre più assidua tra i due nasce un duraturo sodalizio, umano e professionale. Come già avevano fatto Arbasino e Alberto Moravia, Pasolini scrive per lei diverse canzoni, difendendo il suo modo di fare teatro, a metà tra il cantato e il recitato, definendola l’artista teatrale “più consapevole e compromessa”. Il regista la chiamerà ben cinque volte a recitare nei suoi film, in ruoli molto diversi tra loro: dalla giovane diva altera e snob della Ricotta (1963), sino all’appesantita e lussuriosa donna di Bath ne I Racconti di Canterbury(1972).
L’altro polo ideale degli affetti di Pasolini, negli stessi anni, è Ninetto Davoli. Tipico quindicenne di borgata, riccio incosciente e spensierato, Ninetto era andato con alcuni amici a curiosare sul set de La Ricotta. Lì Pasolini lo nota e lo elegge da subito a sua musa insostituibile, soggetto di una serie di ritratti, amico inseparabile, destinatario delle più belle poesie e attore scelto per ben dieci film (dal Vangelo secondo Matteodel 1964 sino a Il fiore delle mille e una notte del 1974). Uno sguardo d’insieme ai disegni qui presentati e realizzati a pennarello, inchiostro o pastelli colorati, restituisce la complessità del rapporto che ha legato i due e le diverse proiezioni dell’immaginario di Pasolini sulla figura del suo Ninetto: un po’ bambino innocente, un po’ rude borgataro, un po’ tenero amante.
I NIPOTINI DELL’INGEGNERE
Stanza 3
Con lo “sketch” pubblicato su il Verri, I nipotini dell’Ingegnere e il gatto di casa De Feo (1960), Alberto Arbasino conia un’espressione che restituisce sinteticamente la complessità di una serie di rapporti umani e letterari che hanno legato i “ventenni degli anni ‘50” allo scrittore Carlo Emilio Gadda. I tre nipotini “venuti fuori pressappoco insieme intorno al ‘55, covati tutti da Paragone” sono Pasolini, Giovanni Testori e lo stesso Arbasino. L’ingegner Gadda a quella data “aveva già più di sessant’anni, scriveva da più di trenta e non aveva ancora pubblicato in volume il Pasticciaccio” e veniva da loro considerato il “massimo autore italiano del mezzo secolo, con immenso dispetto di tutti gli altri”. In direzione verticale Arbasino indica il debito verso Gadda della propria generazione che ha trovato in lui l’autorizzazione a seguire una propria sperimentazione linguistica in una letteratura liberata da “ogni soggezione e complesso verso alti ‘ordini’ o ‘sfere’ per restituirle la sua dignità di operazione linguistica assoluta”. Si tratta, tuttavia, di una discendenza indiretta, anche perché Gadda, un “elefante deciso a morire solitario”, mai si curò dei suoi nipotini – non figli – “ingombranti, ostinatissimi a farlo segno di una devozione” a tratti addirittura “persecutoria”. Una condivisa “vitalità frenetica e imprudente, sempre allo sbaraglio” unisce invece, in senso orizzontale, Pasolini a Testori e Arbasino: una “divorante ossessione” che è ricerca di una lingua capace di restituire sulla pagina le “passioni umane più scatenate e vissute”. Questa opzione di rapporto con la realtà che esclude imprudentemente la censura, “rimettendo in giuoco tutto, come se davvero dovessero morire tutti domani”, li porta alla scelta di un espressionismo linguistico che tiene conto di registri diversi di scrittura, di stesura e di lessico. Riconsiderando i tre autori in questa più ampia prospettiva di espressionismo linguistico, è apparso chiaro quanto sia vero ciò che Pasolini scrisse riguardo Gadda: “i problemi che la sua lingua propone sulla pagina non vi si esauriscono: tendono a divenire generali. Non si può pensare a Gadda senza pensare a tutto il ‘900 letterario, né a questo senza il particolare ‘800 che locontiene in potenza”. Ed è così che, muovendosi ancor più liberamente nel tempo, si costruisce, per mano di Mario Mondo, un grande puzzle di scrittori che, fino a oggi, hanno scelto, per dirla con Contini, una “ricchissima esperienza plurilinguistica”. In quest’ottica allargata trovano il loro spazio la prima edizione del Pasticciaccio (1957) di Gadda e i Glossari tratti da Ragazzi di vita e Una vita violenta: un elenco di espressioni dialettali, talvolta poi diventate di uso comune.
ROMA E LA PERIFERIA
Stanza 2
In seguito a una denuncia per corruzione di minori e atti osceni in luogo pubblico, nel 1950 Pasolini fugge a Roma con la madre Susanna, dopo essere stato espulso dal PCI di Udine e aver perso il lavoro a Valvasone, dove insegnava dal 1948. Nella capitale si mantiene facendo lavori saltuari a Cinecittà, mentre scrive alacremente le sue prime pagine ambientate a Roma, studiando in presa diretta il dialetto romano, anche grazie a un giovane imbianchino incontrato sulle rive dell’Aniene: Sergio Citti. Parallelamente comincia a frequentare un nutrito gruppo di amici e intellettuali, tra i quali Sandro Penna, Carlo Emilio Gadda, Giorgio Caproni e Attilio Bertolucci. Nel 1951 viene assunto in una scuola media di Ciampino e comincia la sua collaborazione con Paragone, la rivista fondata l’anno precedente da Roberto Longhi. Al centro di questi anni nelle giornate e nelle riflessioni pasoliniane ci sono le borgate: spianate squallide, abbandonate, colme di immondizia, più vicine alle favelas brasiliane che alle grigie periferie industriali del nord Italia. Si muovono tra queste rovine di fabbriche abbandonate, case non finite e già vecchie, una serie di personaggi dai nomi pittoreschi, la cui interiorità elementare si rivela nell’azione, più che nell’affondo psicologico. Nascono così i romanzi Ragazzi di Vita (1955), Una vita violenta (1959), e Il Rio della Grana, poi confluito in Alì dagli occhi azzurri (1965), che “ho pensato contemporaneamente […] negli stessi mesi, negli stessi anni e insieme li ho maturati e elaborati”.
L’occhio già cinematografico dello scrittore Pasolini segue le parabole del Riccetto, di Tommasino, del Piattoletta con un realismo empatico profondo, che si traduce nella ricerca di una lingua il più possibile fedele a quella dei suoi protagonisti: un dialetto rozzo, imbrattato, appreso da “parlanti” molto distanti da lui.
È questa necessità di “mantenere il contatto con la realtà, un contatto fisico, carnale, direi quasi di ordine sensuale” a portare Pasolini al mezzo espressivo della cinepresa: “avvicinarsi al cinema è stato quindi avvicinarsi ad una tecnica nuova che già da tempo avevo elaborato nella mia letteratura”.
Lo studio e la dedizione all’immagine cinematografica sembra sostituire, in questi anni, l’espressione puramente grafica ed artistica: i brani dei romanzi romani trovano la loro ideale iconografia nei frame di Accattone (1961), qui riportati dalle pagine della prima edizione della sceneggiatura.
PASOLINI PITTORE NEGLI ANNI QUARANTA
Sono molte le testimonianze di una lunga consuetudine con il disegno di Pier Paolo Pasolini che, fin da quando era bambino, s’intreccia ai primi esperimenti poetici. Negli anni della sua infanzia e giovinezza Pasolini vivrà con la sua famiglia in diverse città di provincia, seguendo i trasferimenti del padre ufficiale dell’esercito: “Hanno fatto di me un nomade”. Punto fermo di questo peregrinare sono le estati al paese natale della madre Susanna, Casarsa della Delizia, in Friuli.
Nel 1939 conclude a Bologna il liceo classico e, a soli diciassette anni, s’iscrive alla facoltà di lettere, dove approfondisce le passioni nate sui banchi di scuola: la poesia, la filologia romanza, le arti figurative, ma anche il calcio e la bicicletta. Nell’anno accademico 1941-1942 riceve la celebre “fulgurazione figurativa” durante il corso sui Fatti di Masolino e Masaccio tenuto da Roberto Longhi. Tra Bologna e il Friuli scrive i versi poi raccolti nel suo primo libro: Poesie a Casarsa (1942), componimenti in friulano notati anche da Gianfranco Contini. Allo stesso tempo disegna e dipinge, prendendo a modello i disegni di ragazzi di Filippo De Pisis. Con la guerra, Pasolini si stabilisce definitivamente a Casarsa: affrontare lo studio della sua produzione grafica e pittorica significa entrare in punta di piedi nello straordinario laboratorio di questi anni.
La serie di disegni del 1942 qui esposta è realizzata su sottili e fragili pellicole, film di cellulosa, che l’autore stesso chiama “cellophane”. Il colore, spremuto direttamente dal tubetto, è lavorato con le dita o con il rovescio del pennello direttamente sul supporto trasparente, sicché è pittura e disegno insieme. I cellophane raffigurano personaggi familiari, come il fratello Guido, con il viso che spunta spaventato dal lenzuolo del letto d’ospedale, dove era stato ricoverato per aver difeso il fratello Pier Paolo in una rissa.
I Giovedì di Pasolini: incontro con dessert
Giovedì 17 maggio 2012, ore 21.00: “Le lucciole sono tornate?”
Conversazione con Silvano Petrosino e Marco Dotti . Il primo di una serie di dialoghi di approfondimento su tematiche sollevate dalla mostra di Pasolini. Protagonisti di questo primo incontro sono Silvano Petrosino, docente di semiotica in Università Cattolica e Marco Dotti, giornalista, curatore del fascicolo Pasolini e noi. A tema della conversazione, il famoso articolo delle lucciole che Pasolini scrisse sul Corriere della Sera nel 1974. Le lucciole per Pasolini erano il simbolo di una società capace di segnare e di desiderare che la modernizzazione omologante delle civiltà dei consumi stava invece cancellando. Quanto delle profezie anticipate in quelle pagine si sono davvero avverate? E quanto la visione di Pasolini ci riguarda ancora da vicino?
Giovedi 14 giugno 2012 alle 21.00
Aurelio Picca presenta Addio
Il nuovo romanzo a Casa Testori, mentre è in svolgimento la mostra su Pasolini. La coincidenza non è affatto casuale: il romanzo di Picca affronta un tema molto “pasoliniano” come quello della perdita dell’innocenza dell’Italia. Una perdita dell’innocenza collocata cronologicamente negli anni’60, ultima stagione mitica della nostra storia collettiva a cui Picca mette un termine simbolico nel delitto Lavorini, il bambino ucciso a Viareggio. Picca ha un vitalismo che sarebbe certamente piaciuto a Pasolini. Ma c’è un altro punto di contatto con la mostra: lo scrittore infatti ha presentato in catalogo uno degli otto film che vengono proiettati al secondo piano, La ricotta. E proprio con una proiezione de La ricotta si concluderà la serata che prevede l’intervento di Luca Doninelli e un’intervista all’autore di Addio.
Roma, Los Angeles, Viareggio. Tre città , tre luoghi dell’immaginario popolare, che qui si incentra sul mito degli anni sessanta, rivissuto dal protagonista, Alfredo. Un ragazzo innocente e destinato a perdere questa innocenza, nell’attrito che gli oppone una vita violenta, tra riformatorio e bar di periferia, ai sogni della giovinezza, tutti convergenti verso quegli anni leggendari, contenitori magici di tutto e nulla: i film di James Dean, le moto rombanti, le Cinquecento Fiat e le Giulie Super Alfa Horneo, i cantanti melodici, i concerti di Gianni Morandi, i discorsi di Almirante, l’omicidio di Kennedy e quello di Sharon Tate. Fatti che sembravano simboli universali, di un qualcosa che forse non c’era e non c’è, ma che si legava a un ribellismo difficile da dimenticare, perchè legato al senso di un’esistenza che desiderava a più non posso essere diversa e libera. Dal profondo delle realtà metropolitane agli anni di piombo il passo è stato nulla più di un grande salto. Ciò che vi sta in mezzo è il racconto che ci offre Aurelio Picca. Un inno all’imprevedibilità della vita umana, sorretto in punta di penna da una profonda nostalgia.
Per l’occasione la mostra resterà aperta fino alle 24.
WORKSHOP ROTHKO
22 Settembre 2012
Capire uno dei grandi artisti del secondo Novecento. E, soprattutto, capire le importanti implicazioni che la sua esperienza ha oggi sul lavoro di chi lavora in ambito artistico, creativo in senso lato o nell’insegnamento. Questo l’obiettivo che si è posto il Workshop Rothko, momento di conoscenza, riflessione e confronto che ha preso spunto dalla pubblicazione di un libro di Silvano Petrosino, filosofo e docente di semiotica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Abitare l’arte, Interlinea editore).
Nel suo libro Petrosino propone un’affascinante interpretazione del grande artista, in quanto protagonista di una rottura con il soggettivismo che domina tanta arte del Novecento. Rothko come autore in cui la solidità della grande tradizione riesce a esprimersi e prendere forma dentro i codici più estremi dell’arte moderna. È attorno a questo affascinante paradosso che Silvano Petrosino ha lanciato e guidato la riflessione, avvalendosi anche di importanti contributi che si sono alternati nel corso del workshop.
Francesco Tedeschi, docente di Storia dell’Arte Contemporanea all’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha introdotto i partecipanti nel lavoro del pittore, raccontandone gli esordi surrealisti.
Ferdinando Bruni, attore e protagonista di Rosso, uno spettacolo teatrale tratto dall’omonimo libro di John Logan e dedicato a Rothko, ha parlato del proprio coinvolgimento con l’artista. Lo spettacolo, in scena al Teatro Elfo Puccini, indaga il tempestoso percorso di pensiero che portava Rothko alla genesi della sua opera. Un percorso che dimostra di prestarsi sorprendentemente a uno sviluppo drammaturgico.
Infine Massimo Kaufmann, uno dei maggiori artisti attivi sulla scena di Milano oggi, e protagonista di una recente mostra al MamBo di Bologna, ha sviluppato una riflessione su quanto Rothko abbia innovato il tema del colore, la sua portata emotiva e simbolica.
Davide Rivalta, RINOCERONTE
Giardino
Afferma il critico John Berger: “Quando sono intenti a esaminare un uomo, gli occhi di un animale sono vigili e diffidenti. Quel medesimo animale può benissimo guardare nello stesso modo un’altra specie. Non riserva uno sguardo speciale all’uomo. Ma nessun’altra specie, a eccezione dell’uomo, riconoscerà come familiare lo sguardo dell’animale. Gli altri animali vengono tenuti a distanza da quello sguardo. L’uomo diventa consapevole di se stesso nel ricambiarlo. L’animale lo scruta attraverso uno stretto abisso di non-comprensione. Ecco perché l’uomo può sorprendere l’animale. Eppure anche l’animale – perfino se è domestico – può sorprendere l’uomo.”
Ma come? Provando una indeterminata nostalgia per una ferinità che c’era e non esiste più, per un richiamo alla natura che non è del tutto sopito sotto spessi strati di civilizzazione. Ecco che l’uomo si prodiga per segregare animali domestici, per costruire e visitare zoo, nell’inutile ricerca di quello sguardo, dell’occhio dell’animale che però, completamente snaturato, non si ferma se non per un istante a osservare il visitatore, per poi dirigersi ciecamente al di là , oltre, perché nulla più può occupare un luogo centrale nella sua attenzione.
Cerco di riproporre quel dualismo che è andato completamente perduto nel momento in cui l’uomo si è sentito signore e padrone della natura. Il dualismo dello sguardo tra la specie-uomo e gli occhi degli altri viventi: la mia opera vuole proporre l’incontro sorprendente, fecondo perché sottratto dall’elaborazione artistica all’anestetizzazione del presente, l’incontro tra l’uomo e l’animale.
Davide Rivalta
Lo scopo dell’artista è allora quello di fissare la possibilità di un vero e proprio incontro fra tre elementi diversi: la figura dell’animale in forma di scultura che pur se fatta ad arte mantiene la propria caratteristica innocente sacralità, la propria naturalezza, e, pur non potendosi sottrarre del tutto alle sempre possibili associazioni simboliche, prendendone le distanze in virtù del proprio “realismo” di fattura; il contesto ambientale in cui si trova ad essere e su cui non tende né a prevaricare né a orientare, bensì solo ad esservi come ospite ingrato; e infine tutti coloro che si troveranno per scelta, per consuetudine o per caso, a confrontarvisi. Si viene così a stabilire un gioco di relazioni che è la sostanza vera e ultima dell’opera, più di quanto non lo siano i suoi connotati stilistici e formali. Consiste questa sostanza nell’evocazione di un senso positivo della vita nelle sue più elementari manifestazioni quali quelle offerte dalla casualità dell’esistere e dalle potenzialità percettive che ci raccordano con il mondo e l’altro-da-sé nell’ambito di quello spazio condiviso, e non esclusivo, a cui nessuna forma vivente si può alla fine sottrarre. Tutto tende allora verso la meraviglia, che è pari nel rappresentato e nell’osservatore, nel visto e nel vedente, quasi a voler indicare quell’unità primigenia che è il nostro e più vero paradiso perduto.
Pier Luigi Tazzi
Davide Rivalta è nato nel 1974 a Bologna, dove vive e lavora.
Ettore Frani, RESPIRI
Stanza 22
Porre il corpo dentro l’anima e non viceversa.
Non l’opera nella stanza ma la stanza dentro l’opera, intreccio tra profondità e superficie, scambio osmotico tra viscerale e atmosferico.
Liberare aperture, nella speranza che l’opera possa accogliere le vestigia di questa epifania.
Una lingua indecifrabile trapela dalle pareti mute, e l’opera si fa orecchio, conchiglia accarezzata dalla spuma sulla rena.
Il tempo è unzione che sgorga e secca.
Toccare con gli occhi il tempo, il silenzio appeso alle pareti.
Bisogna che l’immagine respiri con esse, che si faccia soglia misteriosa.
Nel respiro c’è qualcosa che ritorna e svanisce continuamente, movimento anadiomene che suggerisce e non mostra.
Ciò che resta celato è maggiore di ciò che si esibisce.
Il respiro non conosce distinzione tra esterno ed interno, tra mio e tuo, tra individuale e universale.
Nel respiro c’è contagio, attraversamento, trasudo, umore interstiziale tra la pelle dell’opera e le vesti della stanza.
Sei opere per custodire e rivelare ciò che non può essere mostrato.
Non ci sono che resti, piccole sopravvivenze che l’opera tenta di tracciare.
Un cuore vivo riscalda i bianchi, e la superficie si scopre ricettacolo d’attesa e desiderio.
Ettore Frani
La poetica di Frani si conferma innanzitutto come una poetica del velo e dell’attesa. Egli sa interrogare la superficie della tela e la superficie del mondo perché vi sa vedere la profondità che vi è implicata. È nella superficie che infatti si dà il quadro e si dà il mondo. Ma, come diceva Nietzsche, sarebbe del tutto ingenuo pensare che la superficie sia di per sé superficiale, cioè contrapposta al vero essere del mondo, come una parte caduca e secondaria rispetto alla centralità sostanziale dell’essenza. No, Frani lavora sulla superficie ponendo nella superficie il mistero del mondo, la sua contingenza illimitata.
I suoi bianchi sono il frutto di stratificazioni di colore multiple, meticolose, liriche e, insieme, insistenti e accanite. La pace che egli raggiunge al termine dell’opera è ottenuta attraverso un lavoro tenace. Il suo bianco non è affatto un dato di partenza. Egli non parte dalla superficie, ma la raggiunge. I suoi bianchi sono così sempre popolati da macchie, ombre, presenze, piccole incisioni, scavi impercettibili, densità discontinue su uno sfondo solo apparentemente omogeneo. Il suo sforzo monocromo ruota in modo privilegiato attorno all’oscillazione dell’assenza nella presenza e viceversa. Frani costruisce i suoi bianchi attraverso la pittura e in questa costruzione eleva la superficie alla dignità di un mistero.
Il velo non ricopre l’essenza, non occulta il mistero, non nasconde il mondo. Il velo è il mondo; non c’è mondo senza velo. Il mistero del mondo è tutt’uno col mistero del velo.
Massimo Recalcati
Ettore Frani è nato a Termoli (CB) nel 1978. Vive e lavora a Roma.
Corrado Abate, WUNDERKAMMER
Stanza 21
Wunderkammer (Camera delle meraviglie) è un’espressione appartenente alla lingua tedesca, usata per indicare particolari ambienti nei quali, dal XVI secolo al XVIII secolo, i collezionisti erano soliti conservare raccolte di oggetti straordinari. Per un certo verso possono essere considerati lo stadio embrionale dei musei contemporanei. Tutti gli oggetti che destavano meraviglia erano strettamente legati all’idea di possesso da parte dei privati: questo stimolò la crescita e la diffusione del collezionismo. Scopo del collezionista era riuscire ad impossessarsi di oggetti straordinari trovati in natura (naturalia) o creati dall’uomo (artificialia). Più genericamente questi oggetti venivano definiti mirabilia, cose capaci di suscitare ammirazione e sbigottimento.
Con questo nuovo capitolo ho voluto realizzare una stanza che contenesse, ed in qualche modo raccontasse, la meraviglia e lo stupore che provo ascoltando i rumori che stanno dietro al mio lavoro.
Ogni mio gesto, ogni processo creativo, porta con se una conseguenza sonora, una ritmica inconscia che arriva ad influenzare ed ispirare il mio pensiero.
Questa moltitudine di suoni, traduzione della forza applicata alla materia, compone nella mia testa una serie infinita di melodie che da tempo, ossessivamente, cerco di registrare e documentare.
Perché per comprendere pienamente il rapporto fra uno scultore e la sua materia, è indispensabile ascoltare la loro colonna sonora.
Corrado Abate
Corrado Abate agisce sul legno come in un dialogo con un alter ego: ascolta, osserva, assimila tutto ciò che la materia ha da raccontare per poi intervenire ed estrinsecarne l’intima essenza. Il gesto del creare è per l’artista un processo quasi alchemico e sperimentale che utilizza i principi della Chimica e della Fisica per interpretare delle realtà intrinseche. Le spaccature, le bruciature, le penetrazioni sono azioni inflitte a una materia ancora viva, che quindi reagisce e metabolizza nel tempo portandone i segni. Il violento sforzo fisico dell’intervento di Abate compiuto sul legno come entità altra da sé si rivela una forma di autolesionismo: un tentativo di percepire la propria esistenza e ricercare un equilibrio. Si avverte così un legame intenso e profondo dell’artista con le opere: ognuna è il racconto di un rapporto stretto, un’osmosi che imprime nella materia una forte energia e trasmette la sensazione di una connessione con il Tutto.
Maddalena Tibertelli de Pisis
Corrado Abate è nato nel 1977 a Biella, dove vive e lavora.