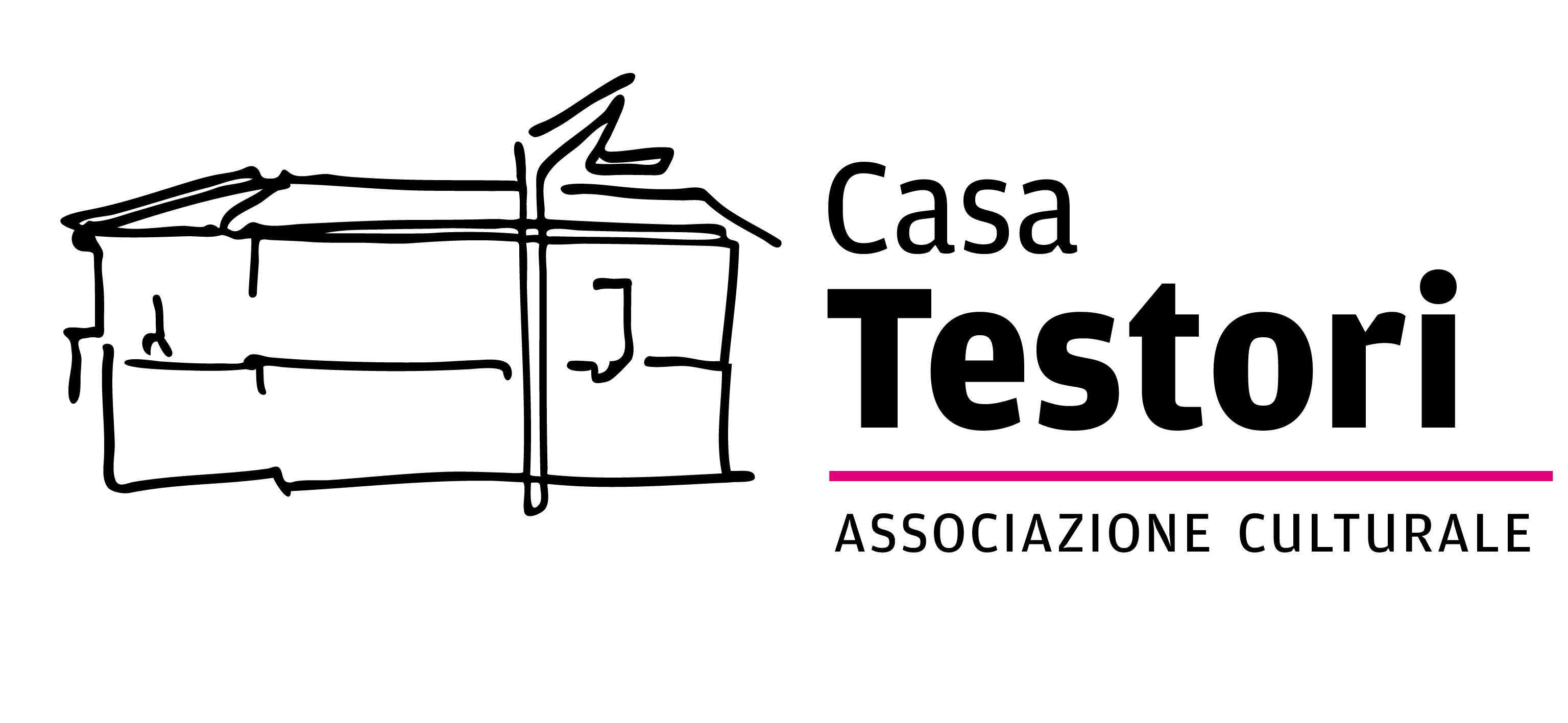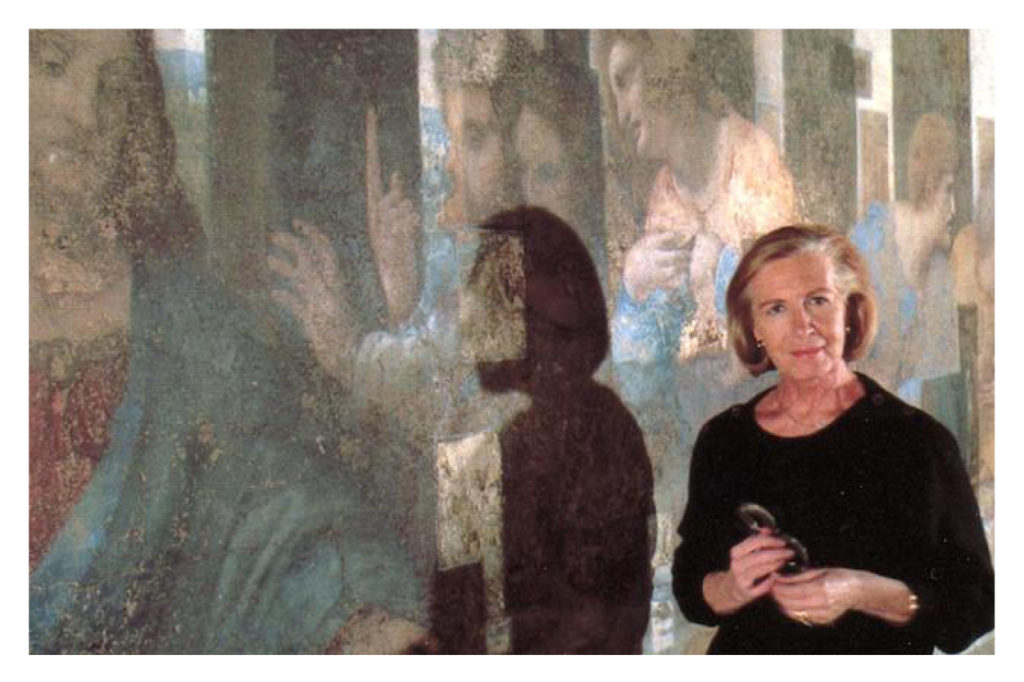È stata una grande amicizia quella tra Giovanni Testori e Paolo Isotta, il grande musicologo napoletano, morto ieri a 70 anni. Era stato Testori a favorire il suo arrivo al “Corriere della Sera” nel 1980, perché diventasse titolare della critica musicale sul quotidiano, dove Testori era responsabile della pagina d’arte. Isotta si era messo in luce per la qualità dei suoi interventi su “Il Giornale” di Indro Montanelli. Il suo arrivo al “Corriere” aveva causato numerosi ostracismi da parte delle istituzioni musicali, intimorite dalla libertà e anche dalla estrema competenza delle sue critiche. Il titolare della critica rimase Duilio Courir (fino al 2010) e nel 2013 Isotta interruppe definitivamente la sua collaborazione con il “Corriere”, dopo che il soprintendente della Scala, Stéphane Lissner, lo aveva dichiarato “persona non gradita” a causa di una sua stroncatura ad un concerto della Filarmonica scaligera diretta da Daniel Harding. Il direttore Ferruccio De Bortoli aveva difeso la libertà di critica, ma l’ostracismo restò nei confronti di Isotta. A testimonianza del rapporto e dell’intesa che si era stabilita con Testori c’è questa recensione di Testori stesso, pubblicata il 30 luglio 1980 sul “Corriere”, a “I sentieri della musica”, libro che raccoglieva interventi critici di Isotta: «libro bellissimo, denso come un’antica enciclopedia, appassionato, intrigante e avventuroso come un grande romanzo».
Voi sapete ch’io v’amo
Giovanni Testori
Corriere della Sera, 30 luglio 1980
«Se la musica è il nutrimento dell’amore, continuate a suonare…»: principia così la più dolce e stregata “commedia d’amore” che si conosca, cioè a dire la Dodicesima notte di Shakespeare. Quando Orsino rivolge queste parole ai musici di corte, ai confortatori della sua malinconia e, insieme, della malinconia che si stende, come un manto di porpora vespertina o di velluto notturno sopra tutta la terra, la tempesta sta facendo approdare sull’isola di cui egli è duca e signore la protagonista dal nome bellissimo e sacrificalmente significativo di Viola. Viola, appunto, d’amore. Il bisticcio m’è venuto da sé; ma riferito a uno degli strumenti, appunto, della musica sembra quasi dalla medesima musica determinato; o evocato. Poiché nell’amore, partitamente e universalmente, risiede il senso della vita, la musica viene qui invocata come nutrimento di lei, la vita.
Ora, che risponde dai suoi nidi nascosti e dai suoi nascosti grembi, la musica all’uomo e alla vita? Forse anche questo potrà parer casuale. Ma letto il corpus degli scritti, casuale non risulta assolutamente più il titolo che Paolo Isotta ha voluto dare al frammento del Suonatore di liuto di Caravaggio scelto per la copertina del suo bellissimo libro; bellissimo, denso come un’antica enciclopedia, appassionato, intrigante e avventuroso come un grande romanzo (I sentieri della musica, Mondadori, L.8.000). Quel titolo riprende le parole del madrigale di Jacques Arcadelt, la cui musica gli specialisti han potuto riconoscere nello spartito che il giovane suonatore, straripante d’adolescente indolenza e d’ambigua, fascinosa bellezza, si tiene spalancato davanti: «voi sapete ch’io v’amo…».
Se l’uomo invoca la musica come nutrimento della propria vita e del proprio destino d’amore, la musica profferisce di risposta all’uomo, «a noi», quanto dire a noi, il suo amore: dunque, la necessità che essa avverte dell’uomo e della di lui vita.
È probabile che in questa stretta, continua eppur liberissima, in questa vera e propria catena di domande e di risposte, di richieste e di offerte, che di per sé è già un atto liturgico, risieda non solo il senso totale che la musica assume per Isotta nella vicenda umana, ma altresì la sua essenza di metafora in ritmi e in suoni del rapporto che intercorre tra l’uomo e il suo creatore, tra l’uomo e Dio. Assieme a tale metafora, a venire enucleata e esaltata, è la natura precipuamente religiosa della musica; e il suo religioso destino. Allontanandosi dal quale e dalle connesse necessità di tempi, azioni e figure liturgiche, la musica s’allontana da sé, esce dal proprio centro, s’opacizza, si tradisce, rantola, forse urla e si suicida, certo si spegne e muore.
Pienissimo, stipato, come se tutta la storia della musica vi fosse chiusa dentro (ciò che in effetti, come vedremo, accade ad ogni pagina), lucente sempre d’una scrittura che domina la materia e le stesse, variatissime occasioni di lettura e d’interpretazione, ma capace nello stesso tempo di soffrire fino allo spasimo (e trascinando in tale spasimo il nitore stesso, il cristallo, ecco, del proprio stile); capace di soffrire, dicevo, i vagiti dell’apparire della musica e della sua fatalità dentro i primi gesti che l’uomo ha compiuto dentro le prime pietre che ha mosso e levigato per dar loro una forma (vagiti nei quali è già tutto contenuto della potenza e dell’eloquenza che quella fatalità andrà assumendo nel giro dei secoli); capace di soffrire, poi, i tempi supremi della gloria e di congioirne; e di soffrire, infine, la caduta verso l’abisso, che forse è altrettanto fatale come i vagiti del principio (atto, questo, che sta racchiuso nei capitoli ultimi del libro, che risultano i più alti, dolorosi e partecipi che sulla musica moderna siano mai stati scritti, proprio perché in essi la musica intesa come “consumazione”, come rantolo ed agonia); pienissimo e stipato nella sua lucidità che s’indora di stupende speculazioni, s’oscura di strazi e d’inabissamenti, accetta, abbraccia, glorifica, rifiuta, sferza e s’indigna senza mai cedere d’un millimetro al suo specchiatissimo ordine (anche quando si trova impegnato in un corpo-a-corpo col disordine), il libro di Isotta diventa così la guida attraverso cui egli ci insegna che la musica è un atto precipuamente rituale e che la funzione sua sta appunto nell’enucleare ogni volta e ad ogni incontro tale verità e nel trasformarla poi in coscienza dove forma ed eticità coincidono, fanno blocco e si stabiliscono per sempre come unità.
Per questa via, anzi per questi sentieri isottiani che procombono verso le origini, quelle origini che noi avremmo pensato inattingibili (e ciò accade nel capitolo La musica delle pietre, forse il più emozionante di tutto il libro, certo quello che si spalanca all’ampiezza d’un vero, grande e misterioso racconto poematico); toccano i vertici della possibilità stessa di partecipazione e di trasposizione in parole nel grande tempio o colonnato dorico-nibelungico dedicato a Wagner; e, passo dietro passo, si preparano poi, come in una cupa eppur doverosa quaresima, a scendere nell’inferno della rottura e dello squilibrio; quindi, ancora più oltre, nell’asettico pantano delle ceneri presenti; per questa via, dicevo, gli scritti di Isotta superano e cancellano la riduzione della musica a fatto meramente storicistico o, peggio ancora, a fatto meramente sociologico cui da anni ci avevano abituati le ideologie che gli ingranaggi critici e burocratici della musica dispongono e governano, finendo, come sono finiti, nell’incapacità medesima ad ascoltare prima e a riferire e scrivere sull’ascolto, poi. La superano e cancellano in quanto l’indagine risulta condotta su di una conoscenza capillare del tessuto storico da cui, di volta in volta, la musica s’è alzata per celebrare le sue certezze e le sue paure, le sue feste e le sue penitenze, le sue glorie e le sue tombe.
Isotta ci ammonisce così che la musica, come tutte le espressioni dell’arte, non è serva di quel tessuto e, men che meno, come usa sostenersi e farsi oggidì, non è serva degli interessi cupamente politici delle ideologie che di quel tessuto vorrebbero impadronirsi per sempre (mentre, nel profondo della realtà, è già caduto dalle loro mani). La musica, egli dice, esprime l’uomo; e solo l’uomo ama e serve. Ma il suo amore e il suo servizio sono di natura, di qualità e di luce supremamente etiche.
Ora è proprio questa coscienza generale del destino della musica, che diventa una cosa sola col destino religioso e, dunque totale dell’uomo, a permettere ad Isotta il miracolo critico che, a mia memoria, nella nostra cultura era stato solo di Roberto Longhi: quello di saper contenere dentro la disanima di un frammento, anche il più modesto, anche il più breve, l’intera storia di quel destino: di saper contenere nel particolare il tutto. Così dentro ogni sua pagina, anche là dove essa diventa filologica perquisizione delle zone più minute e delle più minute connessioni di significati, rapporti, influenze e confluenze, noi avvertiamo premere sempre il rombo dell’immensa arcata che la storia della musica ha costruito sulla nostra terra. L’atto critico sale così di gradi e diventa, in Isotta, atto creativo.
Se è vero che la «poesia nasce in primis sulla poesia» (com’era solito dire, appunto, Roberto Longhi), è altrettanto vero che la musica nasce in primis sulla musica; e che, senza nulla lasciare della loro condizione di partenza e persino di cronaca, gli scritti di Isotta, raccontandoci la storia della musica, compongono una loro, indimenticabile musica; quella che ne forma il fascino, l’attrazione e lo stile. Per cui ci basta un attacco o persino un titolo per avvertirci che è lui il mentore, il pastore che sta conducendoci lungo i sublimi, gloriosi, straziati “sentieri”; e per dirci altresì quale suono dal suo flauto il mentore e pastore farà giungere al nostro cuore. Insomma, per finire con un’altra citazione letteraria, cavata da quel poeta a me carissimo che fu Verlaine: de la musique avant toute chose. Anche nella musica, ecco, prima di tutto, musica. Una musica trasparente e solenne che è felicità di se stessa perché insieme e sempre è coscienza del destino degli uomini e del loro primo ed ultimo significato.